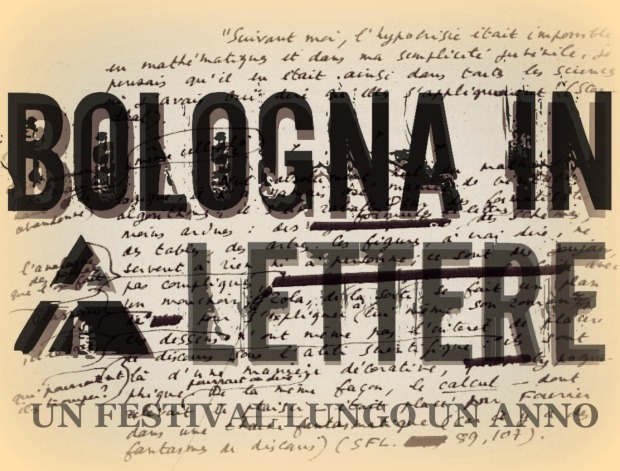Premio Bologna in Lettere
IV edizione
2018
SEZIONE C
Poesie singole inedite
Presidente della giuria
Enzo Campi
Giurati
Francesca Del Moro, Loredana Magazzeni, Giacomo Cerrai
Antonella Pierangeli, Maria Luisa Vezzali
FINALISTI
Elena Cattaneo, Mi culla mia madre
Fabrizio Bregoli, Alba pratalia
Mara Mattoscio, L’inascoltato, la rotaia è ciò che resta
Andrea Donaera, Il padre. Un’ustione
Elena Micheletti, Alzheimer
Alessandro Silva, Il cuore di mio figlio
PRIMO CLASSIFICATO
Andrea Donaera, Il padre. Un’ustione
ANDREA DONAERA
Il padre. Un’ustione
Se bisogna che la cosa si perda per essere rappresentata, “Il padre. Un’ustione” del poeta pugliese Andrea Donaera rappresenta un esatto meccanismo testuale in tre tempi per l’accerchiamento della perdita. Un meccanismo che utilizza la forma triadica non per tendere a un impossibile processo dialettico, bensì per mettere in gioco il martirio del soggetto simbolico attraverso la compilazione di un catalogo affettivo (i fumetti, i presepi, le matite, i temperini…) come regressione al profondo, complice la convocazione di tre autori esemplari della chiusura edipica: un contemporaneo esplicitato in esergo (Michele Mari, «adesso poteva tornare, e seppellirsi nel letto») e due pietre fondanti del moderno con le allusioni iniziali della «blatta sul tuo cuscino» (Kafka) e della «fontana tutta sangue» (Baudelaire). Nella prima sezione il «Grande Altro» paterno è già irrimediabilmente perduto all’esperienza e introiettato nell’immaginazione: «Ti immagino, ormai: e basta». La scrittura, per quanto franta, si trattiene all’interno della consolazione retorica, con la disseminazione di versi tradizionali, le anafore, le epifore, le ripetizioni che alludono al liturgico dell’atto di dolore («e quanto mi pento, quanto mi pento»). La seconda parte estremizza la regolarità metrica costruendosi di prevalenza sull’endecasillabo, ma tematicamente introduce i materiali sdrucciolosi dell’onirico. Qui il paesaggio si sfalda nell’acqueo («mare marcio», «meduse tremule»), ma il risultato dell’immersione in questo «bagnare incessante» è, concorde al discorso bilogico del sogno, un precipitato di polvere. Si arriva così alla terza sezione, dove è messo in scena l’agon («la lotta è… per non riconoscerti») e il destino di conflitto sbaraglia il verso per tramutarlo in un flusso continuo, o piuttosto continuamente interrotto da parentesi quadre, tonde, più che chiuse «socchiuse», virgole, il cozzo dei mai e dei sempre, tra sgretolamento e ricomposizione fino alla sospensione finale del soggetto in un’infanzia pietrificata nel desiderio («pulisci il mio mento sporco di gelato»). (Maria Luisa Vezzali)
ELENA CATTANEO
Mi culla mia madre
I tre testi offerti alla lettura da Elena Cattaneo ci dicono la complessità di una condizione esistenziale, quella delle donne, che non si limita a circoscrivere un orizzonte esperienziale privato ma si allarga a comprendere una più vasta umanità, fatta di solidarietà e condivisione. La carezza della madre che non riesce a toccare la pelle della figlia (Mi culla mia madre, /sono sfera rassicurante./ Non mi accarezza,/ sono fatta di idee, /ritagli di riviste./Senza ossa) diviene urticante tocco d’ortica, impossibilità di cammino sicuro (Questa donna ha mani d’ortica/ braccia imbavagliate/ piedi di sirena), ma anche riconoscimento di altri corpi, altre maternità lontane da noi eppure presenti e vive, della poesia “Antipodi”: (Ecco la mia carezza/ a dire che siamo uguali,/ madri agli antipodi,/sorelle nel cuore). Lo fa con una modalità di racconto visionaria e crudele: la visione non è affrontabile senza dolore, a molti “buca gli occhi”, diventa quell’Immemorabile dire che attiene alla perenne ricerca di sé e dunque alla poesia. Poesia che si guarda bene dallo scivolare liquido e inoffensivo del poetese, ma cerca snodi, slogature, punti di sutura che saltano per dire la complessa realtà del presente e le sue contraddizioni. (Loredana Magazzeni)
ELENA MICHELETTI
Alzheimer
Cos’è che caratterizza la poesia di Elena Micheletti? Forse una certa capacità di rappresentare che il mondo non è che una costellazione di frammenti di dolore, ciascuno dei quali ha bisogno di essere ridotto ad un lacerto comprensibile, o forse soltanto umanamente sostenibile, da chi sia capace di volgervi uno sguardo consapevole, che va come quello di Elena dalla periferia del paesaggio al centro delle cose. Elena crede che la poesia serva anche a questo, proprio perché capace di evadere da un recinto tristemente razionale, anche quando sembra che non ci sia niente di ragionevole in certi accidenti della vita, per raggiungere una dimensione più alta, forse mitica. Ed ecco ad esempio che un fatto drammatico come una donna, forse una madre, colpita dall’ Alzhheimer, ridotta a una bambola che gioca con le bambole, viene sublimato in un delicato ritorno all’infanzia e ai suoi segni, ad una innocenza che tuttavia non può essere priva di rimpianti perché non cancella il dolore di chi scrive. La poesia di Micheletti è insomma sostenuta da una pietà naturale non priva di speranza, che non cede a nessun patetismo o a crepuscolari malinconie e che non si compiace nemmeno quando l’autrice parla di sé stessa e delle sue afflizioni, e da una notevole capacità di condensazione emotiva, che si esprime anche per mezzo di un linguaggio leggero ed essenziale. (Giacomo Cerrai)
FABRIZIO BREGOLI
Alba pratalia
La poesia di Fabrizio Bregoli, ombreggiata da un vivo senso della labilità delle cose e della loro fuggevolezza, è percorsa da un’ innata attrazione nei confronti della parola e del linguaggio, visti non più come strumento di dominio e controllo della realtà, ma come entità distruttrici che s’alimentano di finzione e di maschere in un desertico baluginare di vuoto: ”Anche il bianco sa ferire, s’annida/ un buio in quel suo lucore d’ossa.”(Alba pratalia). Disseminato di enigmi, perpetuamente alla ricerca di epifanie minime in una mancanza originaria di appartenenza, il versificare di Bregoli si distende in silenzi trattenuti, straniati da una sorta di inarticolato horror vacui che, nella biancheggiante apertura del bellissimo Alba pratalia, accompagna in dissolvenza il meccanico accanirsi della parola verso un graduale processo di dilatazione fonica. L’esigenza estetica da cui prende impulso la poesia di Fabrizio Bregoli non muove infatti dalla ricerca di una voce poetica depurata, siderale, lontana dal lessico della comunicazione quotidiana, ma dal dato sensoriale, dall’immanenza dei luoghi e dei personaggi che bussano alle porte del poetico per essere poi trasferiti sul bianco della pagina attraverso un impasto di immagini e suono: “C’è un mondo che reclama, un accadere/ indenne, laterale: il rinnovato/ corteo delle formiche, compiaciute/ della loro briciola…” (Alba pratalia). E’ proprio l’osservazione di tutto ciò che cade nel giro dello sguardo, e che misura la finitezza della propria rovina, a rendere transitabile la parola e a far sì che si ricongiunga al proprio oggetto, attraverso una tensione lessicale che vede muoversi simultaneamente ritmo e timbro. La poesia si contrassegna infatti per un’attenzione elettiva alla tecnica, sul filo d’una sapienza formale impercettibile, volta a costruire il verso con un’accurata opera di cesellatura, che disegna differenti piani, creando un affascinante e spericolato giuoco d’intersezioni e di rimandi, quasi che il filo del discorso si insegua e ricada continuamente su se stesso, procedendo a spirale piuttosto che in linea retta, vivisezionando il poeta stesso, in un continuo ed illuminante intersecarsi di poetica, meditazione critica ed autoriflessione. Si colgono, nei bellissimi testi qui presentati Alba pratalia, IRINA KRATULOVA (Donor No. 34576148-2, BioTexCom* Inc. – Kiev), Pancabbestia, moduli compositivi desolatamente intessuti di una leggerezza tragica, quasi espressionista, coagulata in un roccioso realismo delle immagini che si stempera nella pur presente concretezza delle cose e nella sua aspra dissonanza: ”La dotazione è minima: un violino/ tarlato, un labrador, fornello a gas:/ numeri d’un terno mancato.” (Pancabbestia). Qui la desolazione spettrale di un viaggio al limite della sopravvivenza evoca un vitalismo macabro, dai tratti oscuri di un bagaglio coatto e difforme con cui affrontare l’esistere, manifestando montalianamente una lontana funzione salvifica attraverso la memoria del reale “spilla da balia che raccorda/ il cielo al nulla” (Pancabbestia). L’immagine feticcio di questi testi, tutta giocata sulla connotazione di “un accadere prima che scada il tempo d’una conta” (Alba Pratalia metafora, d’altronde, dello sgranarsi del tempo come per un implodere e contrarsi di macerie e rovine) ha la consapevolezza amara e implacabile di uno stile che spazia senza sussulti dal registro alto a quello quotidiano, secondo un modus scribendi proprio di tutti i testi di Bregoli:”Qui si sconfina come a terra franca la satira di un sole, o la sua surroga” (IRINA KRATULOVA (Donor No. 34576148-2, BioTexCom* Inc. – Kiev). E’ proprio in questo spazio disumano, sapientemente contaminato di suggestioni inquietanti, sottese al tema della labilità irreversibile e tragicamente rivissuta di uomini e cose, che la poesia di Bregoli appare sempre più intessuta di echi fittissimi, che sovente gli servono per evocare scenarî di squallida e grigia quotidianità, di ascendenza eliotiana, nei quali le figure stesse della realtà, smessa ogni suggestione lirica, sono solo una pallida immagine dell’inferno terreno, la cui ambientazione è quella delle traiettorie desolate e livide di hopperiana nostalgia. Metafora e luogo elettivo d’una disperata vitalità, costituita per metà dal transitorio, dal fuggitivo e dal contingente, e per l’altra metà dall’eterno e dall’immutabile, la poesia di Bregoli lavora a strappare alle immagini del tempo la loro temporalità di eterno presente, costituendosi frammento distonico di una memoria simulacro di quell’aporia del nulla che entra nel campo della poesia solo quando si allontana dal contingente. Passato e presente si allineano dunque in uno speciale tempo dilatato, bergsoniano, che viene a raggelarci in una modernità folgorante, costringendoci nel battito marziale di una dislocata lontananza solo apparente, come “la solitudine di tutte le porte/ dove ho costretto l’esilio dei passi.” (Antonella Pierangeli)
MARA MATTOSCIO
L’inascoltato, la rotaia è ciò che resta
I tre testi presentati da Mara Mattoscio appaiono omogenei, come tre movimenti di un unico poemetto. Ad accomunarli sul piano dello stile è l’utilizzo di un linguaggio ricercato e denso di figure del significante e del significato nonché la vivacità grafica data da versi e strofe di lunghezze e allineamenti differenti e dall’utilizzo di segni grafici quali barre oblique e trattini. Questi ultimi frammentano il discorso facendo coesistere possibili segmentazioni di lettura e suggerendo la possibilità di interpretare i versi come composti a loro volta di unità minori, sorta di sotto-versi. Sul piano tematico, la costante che lega i tre componimenti può essere individuata nella tensione verso una comunicazione che appare per molti versi frustrata. Già la parola “monologo” che dà uniformità ai titoli presuppone un unico parlante piuttosto che uno scambio, un parlante che fin dall’inizio sappiamo inascoltato. Termine, questo, a cui in realtà possiamo riconoscere una duplice valenza così come ad altre espressioni utilizzate nei testi: l’inascoltato da intendersi come sostantivo coincide con “il parlatore”, ma come aggettivo si riferisce a quell’oceano che rappresenta l’immensità dell’inesprimibile, dell’incomunicabile, potremmo dire dell’inconoscibile, che sfugge alla trasposizione verbale. L’oceano tra una conversazione e l’altra è ciò che vanifica gli sforzi del parlatore e dell’ascoltatore, già negati peraltro dalla parola “inesistente” che in posizione di quasi-anafora introduce le prime due strofe. Questa è a sua volta passibile di due interpretazioni: da un lato è ciò che non esiste e dall’altro, filosoficamente, ciò che inesiste. Viene il sospetto che sia il parlatore, che ci parla, sia l’ascoltatore deputato ad accogliere la nostra urgenza espressiva siano da individuarsi in qualche entità superiore, in qualche Dio, oppure, cosa non troppo diversa, un sé virtuale che possa “dire tutte / di luce le parole”, come recita un verso della seconda poesia. Il “dire” resta quindi un anelito, avente del resto come obiettivo l’opera, che con ironia viene catalogata nelle forme di “sovraromanzo supertrattato iperpoema” e “vita detta non detta o poco detta”. Qui si riconoscono i due stereotipati poli letterari, ovvero il tentativo di trascendere, esagerare, sublimare (sovra- super- iper-) oppure fare i conti con la vita nelle varie gradazioni con cui questa si rivela (contrapposizione che si riflette tra il sé virtuale in trionfo sulle idee e il sé di corpo trafitto dalla gente). L’ironia non manca in questi versi elaborati e si può percepire nella scelta del verbo “vociare” cui segue la serie allitterante “sillaba sibilo o silenzio”. Mentre le prime poesie si incentrano sulla dinamica del dire, l’ultimo componimento si arricchisce di elementi più concreti, dipingendo meticolosamente un contesto geografico con un procedimento a vortice che chiama e richiama in causa gli stessi elementi: il centro, i confini o margini, i monti e il mare con il porto. E i briganti, che compaiono più volte, protagonisti della storia. Il titolo ci rimanda alle cronache del brigantaggio in Abruzzo, che nella storia d’Italia ebbe spesso risvolti insurrezionali. Ma anche qui torna il tema dell’inascoltato con l’espressione “grande orecchio” già presente nella prima poesia. Un orecchio che, con una sinestesia, è definito “muto” e, ancora, ignaro. All’orecchio viene attribuito un atteggiamento proprio di un corpo intero, in cui si può riconoscere quello della vittima di un’esecuzione sommaria. Se l’orecchio lega il terzo componimento al primo, è il termine “seduta” a ricollegarsi al secondo, segnando il precipitare del ritmo nel fallimento. Nella seconda poesia, sulla sedia d’osso del “mai accadere” il tentativo di dire si smorza in un “lento, bianco, ammutolire” – si pensa allo “scendere nel gorgo muti” di pavesiana memoria – il terzo componimento si chiude con l’identificazione tra l’io e una Medusa seduta nella Storia, laddove la medusa stessa ha la duplice valenza di creatura acquatica (qui preceduta da altre specie) e di Gorgone mitologica, muta presenza passiva, che rimane in silenzio mentre si odono solo annunci di futuri immaginari gridati dai gabbiani. (Francesca Del Moro)
ALESSANDRO SILVA
Il cuore di mio figlio
Una delle cifre stilistiche di Alessandro Silva sta nella capacità di ripensare e rielaborare in maniera articolata e coerente l’eredità trasmessa dalla storia, dal mito, dalle arti. Un procedimento tutt’altro che originale di per sé ma che nei versi di Silva si arricchisce sempre di particolare inventiva attingendo sovente a tradizioni poco diffuse. In questo caso il collante tra i testi presentati è dato dalla religione cristiana che, se da un lato è spogliata della sua aura di sacralità (dissacra è infatti una delle parole che aprono la prima poesia), non è tuttavia completamente ribaltata o satireggiata. Il tono liturgico è già impostato sin dal primo componimento dedicato a un’epifania mattutina, che si apre e si chiude con l’ammissione della nostra pochezza, del nostro essere biblicamente polvere. I versi di Franco Loi citati in epigrafe si fanno portavoce di questa dichiarazione di umiltà e il poeta giunge a sposarla con parole proprie alla fine, ricordando sé stesso come bambino religioso, ma meno generoso di un ateo, ovvero un “niente di memoria del Suo sangue”. Qui viene messa in dubbio la bontà della fede, una prospettiva già delineata dai versi precedenti in cui una serie di Angeli non crea bellezza ma entra in sintonia con la scompostezza del mattino, svergognato nei rumori e nella materialità del dormiveglia, nel disordine del letto. Il volo di Angeli che sputano calce e poi si mutano in pietre castigatrici non è che uno dei molteplici riferimenti biblici in questa sorta di anti-estasi mattutina, dalla scala di Giacobbe alla risurrezione di Lazzaro o di Cristo, dagli agnelli che rimandano al sacrificio di Isacco, fino agli episodi di Sodoma e Gomorra. Motivi religiosi sono presenti anche nella seconda poesia in cui l’essere umano si sposta dal centro dell’universo per confrontarsi con le altre creature, in questo caso i cani, esseri dotati di arcane capacità percettive, dato che “stanno coi nomi dei morti e capiscono il modo in cui si consuma lo spazio bianco delle cose”. Ma i cani hanno un’altra qualità che li rende superiori agli esseri umani: la fiducia. Sta a noi apprenderla da loro, mentre restiamo invischiati nell’eterna lotta tra bene e male, uno scontro che da spirituale diviene fisico, vedendo come antagonisti i demoni malati che ci cuciamo in corpo e il cuore di spine in fiamme di Gesù frenato nella nostra gola. Il cuore torna nel titolo dell’ultima poesia, suggerendo un’identificazione tra “mio figlio” e il figlio di Dio. Nell’immagine del corpo sovrastante un abisso, di cui si colgono solo la schiena e le braccia, sembrano profilarsi la forma della croce e la statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Questa figura sospesa sul vuoto, in cui Dio e l’uomo vengono infine a coincidere, si staglia al centro dell’ultima poesia che insegue il linguaggio della terza cantica dantesca (i tre componimenti potrebbero in effetti riprodurre la scansione dell’oltremondo dantesco), nel tentativo di dire l’indicibile paradisiaco attraverso immagini di grande bellezza: “la mira perfetta del cielo brilla”; “il precipizio di luceargento”, “la cima del fiore che gela orbite / in moto di particelle antiche”. Ma in questi versi pieni di luce, non manca la consapevolezza della nostra miseria. Sotto un cielo post-apocalisse il cui splendore è sporcato da piume lacere e insetti senz’ali, l’uomo sale al fiore sublime ma resta piccola creatura, insignificante, un seme minuscolo e sfibrato che tuttavia si richiama al Seme divino citato nella prima poesia e ha in sé la facoltà di generare. (Francesca Del Moro)